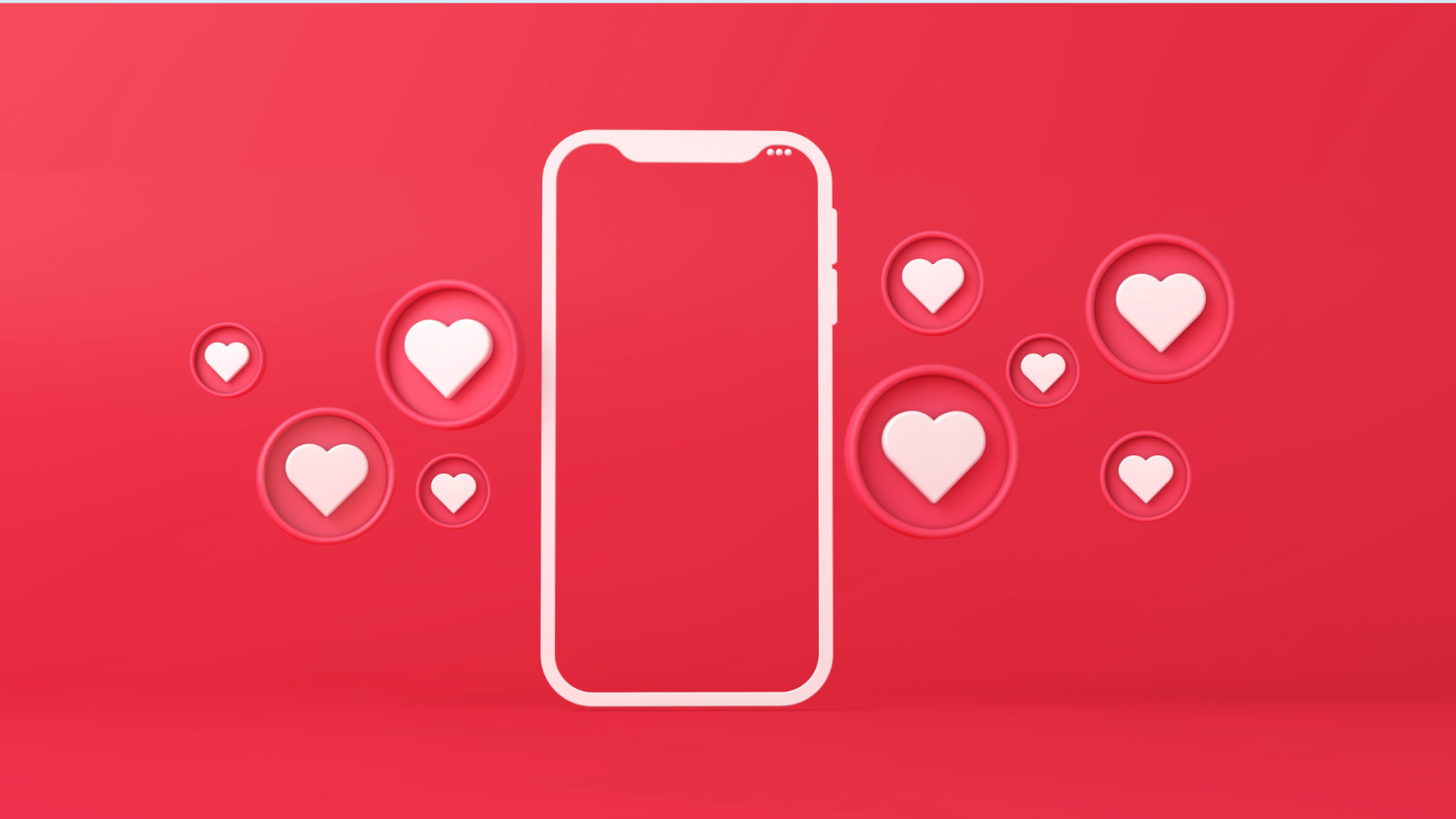Pubblicato il 19/12/2025Tempo di lettura: 5 mins
In principio furono le scoperte scientifiche e gli avanzamenti tecnologici. Poi arrivarono i social. Che il nostro rapporto con la malattia sia profondamente cambiato nel corso dei secoli è evidente: dalla penicillina all’imaging diagnostico, dai vaccini agli interventi chirurgici, abbiamo imparato a curare malattie un tempo letali e identificare, anche in fase precoci, malattie un tempo sconosciute e invisibili. Non è una novità nemmeno che nel corso del tempo siano cambiati i rapporti tra medici e pazienti, né che siano cambiate comunicazione e accesso alle informazioni sui temi sanitari. Molto meno si riflette, però, su come il rapporto con la malattia – sia dal punto di vista di chi la vive, sia di chi la cura – sia cambiato nell’era dei social network.
I social newtork possono piacere o non piacere; c’è chi ci passa ore al giorno e chi non è iscritto a nessuna delle svariate piattaforme disponibili. C’è chi posta e chi si limita a interagire con contenuti altrui. Indipendentemente da quanto e come li si viva, però, c’è un aspetto che nessuno di noi può trascurare: sono uno strumento potentissimo. Proprio per questo capire il loro ruolo nelle diverse sfere della vita quotidiana diventa fondamentale, e proprio qui sta il merito di #Malati. Com’è cambiato il nostro modo di stare male (o bene) nell’era dei social network (Codice Edizioni, 2025) di Cinzia Pozzi, che lo indaga dal punto di vista della malattia.
«La condivisione è il nostro credo, e i social sono le nostre chiese», scrive Pozzi. Che ci piaccia o meno, quindi, tanto vale imparare a confrontarci con questa realtà (forse, si spera, non così assoluta). Per una persona con una malattia, cosa significa trovare sui social persone con la stessa malattia? Per chi quella malattia la racconta, cosa significa avere una community che segue la sua esperienza? Per chi la cura, cosa significa confrontarsi (oltre che col “dottor Google”) con la realtà dei social?
In #Malati ci sono tante riflessioni, troppe per una recensione. Partiamo però da una base: i social non sono la prima esperienza di condivisione virtuale della malattia. Prima (non tanto tempo fa) c’erano i blog e i forum, luoghi virtuali di aggregazione e scambio di informazioni ed esperienze. La grossa differenza, spiega Pozzi, è che sui social il rapporto non è più “alla pari”: c’è chi gestisce l’account, il content creator, insomma un protagonista intorno cui si raccolgono i follower. Non più tante persone che parlano tra loro, ma una persona che parla a molte. Ma, evidenzia ancora Pozzi, i social danno modo di fare anche un’altra cosa: mantenere un rapporto diretto con la propria community. Si risponde ai direct message e ai commenti, si creano contenuti per rispondere alle domande e alle curiosità dei follower. E non lo si fa più dietro a username più o meno improbabili, ma esponendo, oltre che le proprie emozioni ed esperienze, il proprio volto.
A guidare le dinamiche che ne conseguono c’è un algoritmo. È quello a decidere cosa vediamo, quale contenuto andrà bene e sarà visualizzato da più utenti. Con quali effetti? Spoiler: non possiamo dire buoni o cattivi, perché se c’è una cosa che #Malati rende evidente è che l’avvento dei social network, quando si parla di malattie, ha tanti vantaggi quanti svantaggi. C’è il non sentirsi soli, la possibilità di combattere lo stigma che ancora circonda tante, troppe malattie, c’è una nuova forza fatta dall’unione, che trova anche nuove parole: «Il vocabolario dei pazienti è in continua evoluzione, soprattutto da quando sono diventati anche degli utenti», scrive Pozzi. E nascono «nuove espressioni che riflettono il cambiamento di ruolo del malato, da passivo ricevente di cure ad attivo (almeno in teoria) protagonista della sua salute che oggi si impegna a “normalizzare” la percezione della malattia, ad “abitare” corpi “non conformi” e a impedire che i sintomi e soprattutto le persone che li vivono siano “invisibilizzati”».
Ma, dicevamo, «Ad alimentare un circuito distorto è il solito algoritmo che sostiene la circolazione dei post che “funzionano” senza badare troppo al loro contenuto, dimostrandosi così indifferente alla sofferenza umana». Così, anche senza andare sulle vere e proprie truffe, ci sono per esempio persone ormai guarite, ma che l’algoritmo rende invisibile se i contenuti non continuano a incentrarsi sulla malattia, imprigionandole (virtualmente) su quel tipo di narrazione. C’è anche il rischio, concretissimo, che proprio i social vadano a nutrire alcune malattie: un esempio su tutti, su cui si incentra #Malati, sono i disturbi del comportamento alimentare, con contenuti che dietro l’hashtag #recovery nascondono troppo spesso reel e post che di fatto incentivano il disturbo mentale. E poi, «Se da un lato i social network possono mettere in contatto chi sta male con persone con la stessa diagnosi creando un’opportunità di supporto reciproco tra gli utenti, dall’altro la sostituzione delle conversazioni faccia a faccia con interazioni solo virtuali può spingere le persone con psicopatologie, che vivono le relazioni con difficoltà, a isolarsi maggiormente nella vita oltre gli schermi». E che dire del cyberbullismo, o del rischio di disinformazione, della rinuncia alla privacy?
#Malati affronta tutti questi temi in modo non solo completo ma anche solido, tra interviste con gli esperti (che in questo caso non sono certo solo i medici, ma anche content creator ed esperti in comunicazione e sociologia) e i dati disponibili dagli studi disponibili. Che sì, per ora sono scarsi e frammentati, ma qualche indicazione iniziano a darcela. Non dà risposte nette, perché i social network non sono né il bene né il male. Sono strumenti con cui dobbiamo confrontarci, ci piaccia o meno, e se non altro possiamo scegliere come usarli. Perché «Non è tanto come si evolve la tecnologia a disposizione a contare, quanto come i pazienti-utenti siano consapevoli di questo cambiamento e riescano ad adattarsi a esso».
La migrazione sanitaria in Italia, spiegata bene
Pubblicato il 18/12/2025
Il fenomeno della migrazione sanitaria definisce lo spostamento di cittadini da una Regione all’altra per ricevere assistenza. Il termine tecnico che la definisce è però mobilità sanitaria. Probabilmente il termine migrazione trova largo uso perché giornalisticamente più accattivante e perché caratterizza meglio la componente più significativa dei flussi di mobilità: lo spostamento massiccio di pazienti dal Sud al Nord.