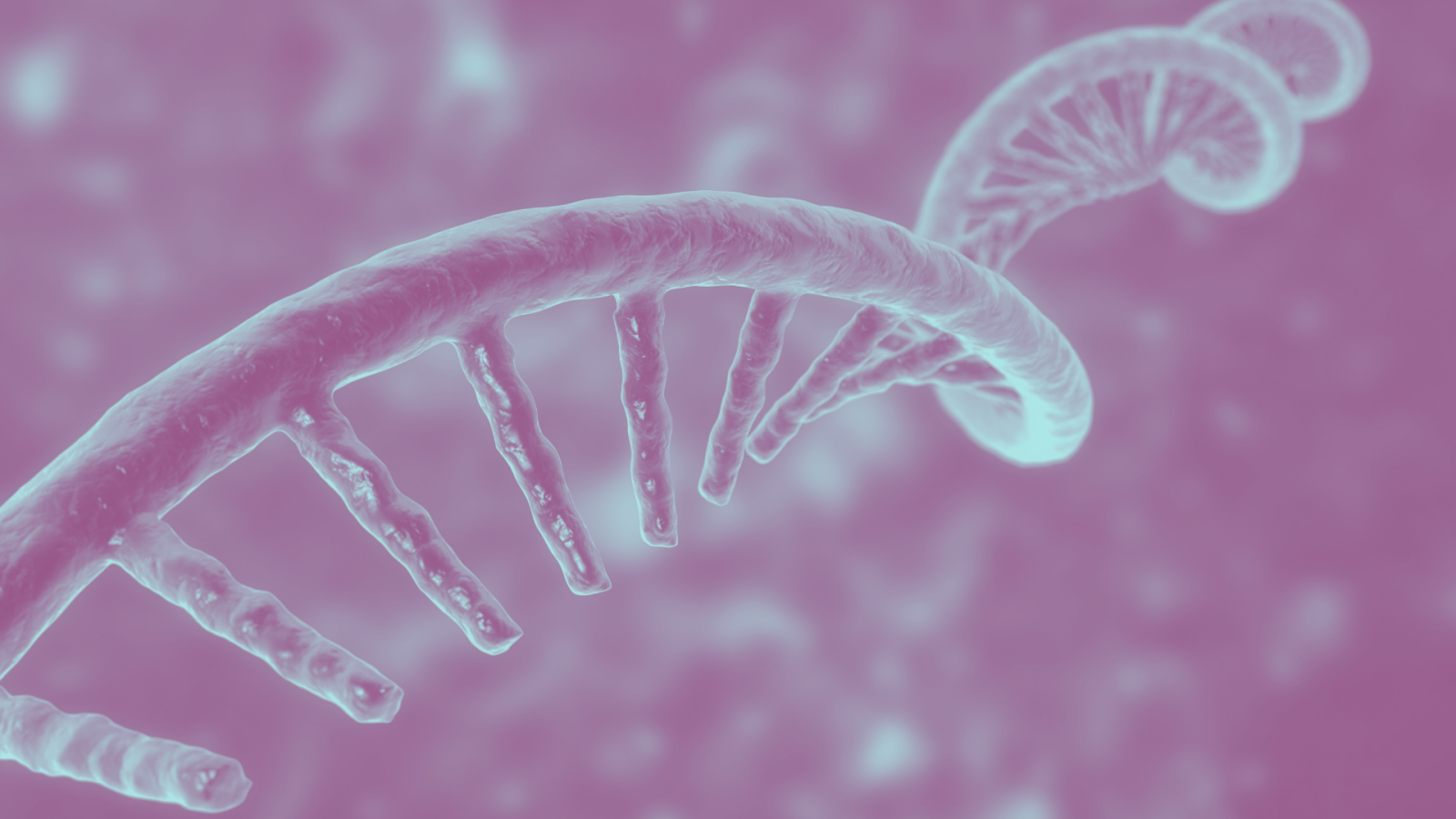Il 22 ottobre è uscito su Nature un articolo che ha avuto molta condivisione, e che ha sicuramente acceso nuove speranze in chi ne ha letto sui media e siti di news. Come sempre succede quando, nel corso della lunga partita a scacchi tra scienza e cancro, la scienza muove un pezzo e mette l’avversario sotto scacco sperando di veder cadere il re in poche mosse.
Questa in particolare è una partita che va avanti da una quarantina di anni tra il cancro e ricercatori che fin da metà degli anni ’80 hanno cercato il modo di usare il sistema immunitario come terapia oncologica in aggiunta o in alternativa alle terapie tradizionali (chirurgia, radioterapia e chemioterapia). Una partita aperta coi tentativi di Steven Rosenberg negli anni ’80 di attivare con IL-2 le cellule T killer LAK (Lymphokine Activated Killer cells) o di isolare dal tumore le cellule TIL (Tumor Infiltrating Lymphocytes) per espanderle ex-vivo e reinfonderle in gran quantità nel paziente.
Poi a fine anni ’90 sono arrivate le scoperte di James Allison e Tasuku Honjo di come il tumore sfrutti i meccanismi di controllo della tolleranza immunitaria nel riconoscimento del self/non-self per neutralizzare i linfociti e rendere l’organismo tollerante alla sua presenza. E quindi i tentativi di inibire quella tolleranza. Nel 2011 e 2014 vengono approvati e messi in commercio i primi inibitori di CTLA-4 e del complesso PD-1/PD-L1, molecole che il cancro usa per nascondersi ai linfociti. Ormai ne sono stati approvati molti con nomi commerciali diversi, chiamiamoli genericamente Immune Checkpoint Inhibitors (ICI). Tante speranze, tanti trial clinici, farmaci approvati per l’uso contro tanti tumori diversi e nel 2018 il premio Nobel meritatissimo per Allison e Honjo.
La risposta non è per tutti
Alla fine, tuttavia, i risultati sono molto buoni per alcuni tumori, molto meno per molti altri. Quelli con cui gli ICI funzionano bene sono tumori caratterizzati da alti livelli di espressione della proteina PD-L1, la cui interazione con PD-1 viene bloccata dagli ICI, e da un fenotipo ipermutatore, ovvero tumori che accumulano molte mutazioni perché nel corso della trasformazione hanno inattivato i sistemi di controllo e riparazione del danno al DNA. Tante mutazioni significa tante proteine dalla struttura alterata, che il sistema immunitario finalmente sbloccato dall’azione degli ICI vede come proteine non-self e quindi attacca le cellule tumorali che le contengono. Quello che era un punto di forza di quei tumori (la capacità di mutare) diventa il loro punto debole. Ma molti altri tumori il sistema immunitario non li vede, i ricercatori li definiscono “freddi”. Così si pensa a come farli diventare “caldi”, sensibilizzando in modo specifico il sistema immunitario. In pratica una specie di vaccino contro il tumore. Decenni di ricerca sull’RNA, sulla sua struttura e regolazione fanno pensare che si possa fare, trovando il modo di veicolarlo nelle cellule per fargli produrre le proteine tumorali che saranno viste come antigeni e attiveranno la risposta immunitaria.
Ma a fine 2019 siamo in pandemia, e quelle idee su come modificare e stabilizzare l’RNA, su come veicolarlo nell’organismo, vengono indirizzate a produrre un vaccino per Covid-19. L’immunità contro la Spike del virus SARS-CoV-2 passa avanti a quella contro il tumore. Intanto comunque, in emergenza, si dimostra che l’idea funziona, e anche molto bene. Perciò, rientrata l’emergenza, si torna a pensare all’immunità contro il tumore. E vedono la luce i primi vaccini a mRNA per il cancro. I primi trial clinici sono molto promettenti.
Vaccini a mRNA, sistema immunitario e cancro
A un vaccino a mRNA contro un glioblastoma (un tumore che risponde poco e male alle terapie convenzionali) in una forma particolarmente resistente alla chemioterapia stanno lavorando anche alcuni degli autori dell’articolo di cui parliamo. Per questo sono interessati all’interazione tra vaccino a mRNA, sistema immunitario e cancro, e sempre per questo vanno a prendersi i dati di sopravvivenza media e a tre anni di due coorti di pazienti (tumore al polmone in fase avanzata, NSCLC, Non Small Cell Lung Cancer stage III/IV e melanoma metastatico) trattati con ICI al MD Anderson Cancer Center (MDACC) in Texas tra il 2015 e il 2022.
Alcuni di quei pazienti sono stati trattati durante la pandemia e hanno ricevuto una o più dosi di vaccino per Covid-19, quelli trattati prima della pandemia no. Così si rende possibile uno studio retrospettivo e comparativo tra pazienti che hanno ricevuto solo ICI e quelli che hanno ricevuto anche un vaccino a mRNA.
I risultati sono sorprendenti. I pazienti con tumore polmonare trattati con ICI più vaccino hanno una sopravvivenza media maggiore (37.3 mesi vs 20.6) e una sopravvivenza a tre anni del 55.7% vs 30.8%. Anche i pazienti con melanoma trattati con ICI più vaccino mostrano risultati analoghi.
Può sembrare poca cosa a chi è abituato ai periodici titoli fuorvianti dei siti di news “Scoperta la cura per il cancro”, ma con quei tumori, in fase così avanzata, non lo è.
In uno studio italiano su 880 pazienti con NSCLC trattati con inibitore di PD-1 la sopravvivenza media è stata di 25,5 mesi. A questo punto gli autori cercano un meccanismo dietro quelle osservazioni. E per trovarlo usano un modello sperimentale murino. Topi inoculati con cellule di linee tumorali ben caratterizzate che cresceranno come tumori simili per caratteristiche a quelli dello studio vengono trattati con ICI e con un equivalente dei vaccini per Covid Pfizer e Moderna, ma ricreati in laboratorio per poterli modificare a necessità.
I dati non lasciano dubbi, il trattamento con vaccino a mRNA, da solo e in misura maggiore se in combinazione con ICI, ha un forte effetto inibitorio sulla crescita dei tumori negli animali, molto maggiore di quello dell’inibitore di PD-1 (ICI) da solo.
La risposta immunitaria al tumore è amplificata dalla reazione al vaccino
Oltre ai vaccini a mRNA per Covid-19 il gruppo di ricerca prova anche un vaccino a mRNA codificante per una proteina completamente diversa, la proteina pp65 del citomegalovirus (CMV). L’effetto dei due vaccini sulla crescita dei tumori è confrontabile, e quindi è presumibilmente dovuto alla combinazione di RNA e nanoparticelle lipidiche più che alla sequenza codificante dell’RNA. Gli autori scoprono che l’associazione è causale. La somministrazione di RNA-LNP innesca nei soggetti vaccinati (sia umani che altri animali) una forte risposta innata.
La risposta innata è la nostra prima linea di difesa: è una reazione aspecifica che viene attivata da una moltitudine di sensori che rispondono alla presenza d molecole recepite come estranee nel nostro organismo. Possono essere virus e batteri ma anche, come in questo caso, semplicemente acidi nucleici, RNA, DNA o molecole di sintesi. La risposta innata consiste nel rilascio rapido di citochine infiammatorie (in questo caso specialmente interferone alfa), che segnalano all’organismo un’emergenza e lo preparano ad affrontarla. Nel caso di agenti infettivi, la risposta innata ha il doppio scopo di cercare di bloccare il microorganismo prima che riesca a entrare e infettare le nostre cellule, e innesca la seconda linea di risposta immunitaria, quella adattativa. La risposta adattativa inizia con l’attivazione di APC (Antigen Presenting Cells), cellule dendritiche e macrofagi, che elimineranno le molecole estranee o le presenteranno al sistema immunitario per indurre la proliferazione e maturazione di linfociti T CD4 e CD8 e di linfociti B che produrranno anticorpi in grado di riconoscere in modo specifico gli antigeni segnalati. Ci torniamo a breve.
Una conferma che la risposta innata e la produzione di interferone alfa siano causati dal vaccino RNA-LNP viene trovata utilizzando per la sintesi delle molecole di RNA dei vaccini a mRNA il nucleoside uridina, che si trova normalmente nel nostro RNA invece della N1-metil-pseudouridina (m1Ψ). Questo nucleoside modificato è stato utilizzato nei vaccini a mRNA per Covid-19 per evitare che i recettori nelle nostre cellule considerassero l’RNA del vaccino come il segnale di un’infezione virale in corso, scatenando una risposta innata eccessiva che si sarebbe risolta con la distruzione completa delle molecole di RNA del vaccino.
Prevedibilmente, l’uso di uridina invece di N1-metil-pseudouridina nei due vaccini a mRNA usati nella sperimentazione aumenta l’intensità della risposta innata e con essa l’attività antitumorale del trattamento. Invece, aggiungendo al trattamento un anticorpo in grado di bloccare il recettore per interferone alfa diminuisce l’attività antitumorale perché l’anticorpo blocca gli effetti della risposta innata. Quello che succede infatti è che, come previsto nel caso dei vaccini a mRNA per Covid-19, la risposta innata attiva la risposta adattativa, ovvero spinge la produzione e la proliferazione di linfociti T e B specifici nel riconoscimento degli antigeni riconosciuti come tali, ovvero pezzi della proteina Spike. In questo caso però oltre alla proteina Spike codificata dal vaccino saranno riconosciuti come antigeni anche le proteine tumorali, che in assenza di attivazione il sistema immunitario non avrebbe visto.
Autori e autrici dimostrano che linfociti T CD8 citotossici, specializzati nell’eliminare le cellule anomale che portano gli antigeni contro cui sono programmati, non solo proliferano aumentando di numero, ma infiltrano anche il tessuto tumorale portando lì la loro attività citotossica.
A questo punto ricordiamo che stiamo assistendo a una partita a scacchi, perciò alla mossa dei ricercatori (indurre la proliferazione di linfociti T citotossici che infiltrano il tessuto tumorale) il cancro risponde aumentando la produzione di PD-L1, la molecola che abbiamo visto neutralizzare i linfociti legando il loro recettore PD-1. Ma il nostro è un trattamento combinato RNA-LNP + ICI, ed è proprio l’azione dell’anticorpo anti-PD-1 che neutralizza la risposta del cancro bloccando il legame PD-1/PD-L1. In questo modo la risposta del cancro viene vanificata, e la reazione immune antitumorale viene preservata risultando negli aumenti di sopravvivenza riscontrati nello studio.
In sintesi, il trattamento combinato RNA-LNP+ICI anche con un RNA non codificante per neoantigeni tumorali, rende caldi (visibili al sistema immunitario) dei tumori freddi e neutralizza la risposta del tumore potenziando l’effetto del trattamento immunoterapico.
Ricerche promettenti a rischio
Ovviamente è prevedibile che, se invece di un vaccino a mRNA per Covid-19 si utilizzasse un vaccino a mRNA specifico per le proteine tumorali, l’effetto antitumorale sarebbe ancora maggiore. Questa è la direzione in cui dovremmo (e dovremo) andare nel futuro. I geni del tumore mutati, anche quelli che non hanno un ruolo particolare nella cancerogenesi, saranno una risorsa preziosa se visti, come finalmente possiamo fare, nel ruolo di neoantigeni specifici per il tumore contro cui attivare il sistema immunitario in un approccio di immunoterapia personalizzata.
Ma ci sono un paio di considerazioni. La prima è che sequenziare con la profondità necessaria un genoma tumorale, isolare i geni che presentano le mutazioni più adatte, sintetizzare gli RNA per il vaccino è una procedura non breve, non semplice, e nemmeno economica. La seconda considerazione è che non è scontato che si possa sempre fare: alcuni tumori non hanno proteine con mutazioni sufficientemente immunogeniche o ne hanno troppo poche. Per questi due motivi, l’utilizzo di un attivatore aspecifico, già approvato, già disponibile in commercio, economico, forse andrebbe tenuto in considerazione.
E per questo motivo sicuramente i dati presentati in questo studio retrospettivo andrebbero approfonditi e convalidati con dei trial clinici, su nuovi pazienti, su tumori diversi.
Tutto questo però succede mentre nel paese che su queste ricerche è più avanti, gli Stati Uniti, il Dipartimento per la salute ha da poco deciso di tagliare di 500 milioni di dollari i finanziamenti da destinare alle ricerche sui vaccini a mRNA. E se al momento c’è molta confusione (ma anche una certa speranza) che questi tagli non riguarderanno i vaccini a mRNA per cancro, questo studio e i suoi approfondimenti, riguarderebbero un vaccino per Covid, quindi tra quelli soggetti ai tagli.
In una recente intervista alla rivista Science Steven Lin, il Principal investigator dello studio pubblicato, spiega che a causa di questa situazione non ha ancora chiesto finanziamenti federali per nuovi studi con cui confermare i risultati.
In aggiunta, i governatori di diversi Stati americani stanno cercando di far approvare leggi che rendano i vaccini a mRNA non più approvati e utilizzabili nel proprio Stato. Lo sarebbero invece come terapia coadiuvante antitumorale? La tecnologia dei vaccini a mRNA contro Covid-19 è stata pubblicamente disincentivata perché considerata non utile, non efficace, pericolosa. Come sarà possibile ora reintrodurla come terapia antitumorale?
Un’ultima considerazione merita di essere fatta. Questa partita a scacchi è cominciata quarant’anni fa nel laboratorio di Steven Rosemberg al National Cancer Institute (NCI), con fondi dello stesso NCI, parte dei National Health Institutes (NIH) federali. È proseguita con decenni di ricerche sulla biologia dell’RNA, sui Check Point Immunitari portata avanti spesso con finanziamenti dei NIH. Tutto quello che abbiamo appena raccontato è stato possibile grazie a quella ricerca di base, finanziata con fondi federali, che il presidente Donald Trump sta facendo di tutto per distruggere coi suoi tagli, le sue censure, i suoi licenziamenti di massa. Tutto questo avrà un impatto nel futuro sotto forma di mancato progresso scientifico, mancate scoperte, meno vite salvate. Forse potrà rimediare la ricerca fatta in altri paesi, da quelli europei alla Cina, ma, almeno per ora, non agli stessi livelli di quello che stiamo perdendo oggi.