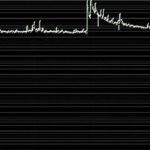Pubblicato il 15/09/2025Tempo di lettura: 3 mins
Martedì, la mia compagna mi sveglia con la più terribile delle notizie: niente caffè, non abbiamo corrente. Appena riesco a fare mente locale, mi rendo conto che i contorni della catastrofe sono più ampi di quanto credessi: neanche il bar all’angolo ha elettricità. Non c’è corrente da nessuna parte. Non c’è internet. Le strade sono vuote. A questo punto l’apocalisse zombie è già quotata a 1,5. Addentiamo un paio di biscotti. Lo smartphone pigola. Un’onda fugace è riuscita a portarci il messaggio di una collega: tutto il quartiere è in blackout, sospetto sabotaggio. Per un po’ ci ostiniamo nella speranza di ritrovare internet. Inutile.
A fine mattina la mia compagna ha un appuntamento con il medico in centro. Dovrà fare il giro lungo per raggiungere dei mezzi funzionanti, ma almeno avrà la possibilità di connettersi con il mondo. Nel tardo pomeriggio, al suo ritorno, la situazione inizia a delinearsi. Il blackout interessa cinque zone nella periferia sud-est di Berlino, coinvolgendo più di 50.000 famiglie, 3.000 aziende e 2 case di cura (l’ospedale ha il generatore d’emergenza), oltre ai tram e la metro. Le tracce di benzina scoperte vicino ai due pali terminali bruciati non lasciano dubbi in merito al dolo. Su internet circola già una presunta rivendicazione di un gruppo anarchico. Obiettivo, «il più vasto parco tecnologico d’Europa», in particolare una decina tra aziende e centri di ricerca coinvolti più o meno direttamente nella guerra (Ucraina, Gaza, ecc.). Le altre ipotesi più masticate parlano di un’azione di false flag dell’alt-right, che (anche) qui in Germania ha un certo pedigree in questo senso; oppure Putin. (Una settimana dopo, al momento in cui si scrive, non si sa ancora niente di certo sui responsabili). In ogni caso, la precisione del colpo fa sospettare una qualche cooperazione all’interno del Servizio per l’energia. Per quanto ci riguarda, abbiamo abbastanza impedimenti tecnici da non poter lavorare e sufficiente gelato sciolto nel freezer da permetterci uno shock di zuccheri mentre ci dilettiamo con tutte le dietrologie possibili.
60 ore. Il nostro circondario è stato l’ultimo a essere riallacciato, giovedì sera. Nel frattempo, hanno dovuto trasferire le persone dalle case di cura. Fortunatamente, non risultano incidenti gravi. Pur con qualche perizia semi-comica, sembra che l’amministrazione e i servizi locali siano riusciti a essere presenti per le strade e assistere chi aveva più bisogno. Con la mia compagna abbiamo fatto in tempo a scongelare le verdure sul barbecue in giardino; andare a caccia di caffè nei quartieri limitrofi; giocare a carte a lume di candela e guardare una notte buia come non l’avevamo mai vista qui in città. Piccole (dis)avventure di un mondo privilegiato.
Eppure, alla fine di tutto, restano i danni e la sensazione che, anche questa volta, abbiamo sbagliato qualcosa come società. Per due tralicci bruciati, ci sono voluti tre giorni a bypassare i circuiti e ridare la corrente a un’area tutto sommato scarsamente popolata. La riparazione effettiva delle linee poi ha già un prospetto di «alcuni mesi» e non ben specificate decine di migliaia di euro. Non è ancora possibile contabilizzare le perdite delle aziende (bellicose o meno che siano), ma per dare un’idea la produzione settimanale complessiva ammonta in media a più di cento milioni di euro. I centri con laboratori e tecnologie di misurazione sembrano essere i più colpiti. In molti casi tornare a pieno regime potrebbe richiedere settimane. E ovviamente c’è già chi pensa a “socializzare” i costi con lavoro extra nei giorni festivi.
Ronald Sillmann, direttore di WISTA GmbH (una società statale che si occupa di promuovere in loco nuove imprese e sinergie tra il mondo scientifico e quello economico), ha dichiarato: «siamo vulnerabili […] è fondamentale trarre gli insegnamenti giusti da questa situazione di crisi e adottare le misure adeguate.» Ineccepibile. Ciononostante, non riesco a non pensare alla Spagna, alla California, all’Italia… a quell’insostenibile leggerezza della prevenzione.
David Baltimore, il Nobel che ha cambiato la biologia molecolare
Pubblicato il 12/09/2025
Ero entrato da poco come studente nel laboratorio di Ematologia e Oncologia dell’Istituto Superiore di Sanità. Per la mia tesi di laurea sperimentale volevo lavorare con i geni, col DNA, con l’RNA… Sono stato fortunatissimo, sarei entrato nel mondo dei geni HOX, e da lì in quello dei tumori. E avrei fatto biologia molecolare, avrei sequenziato il DNA, avrei studiato i promotori dei geni, la loro regolazione, e la loro deregolazione nel cancro.