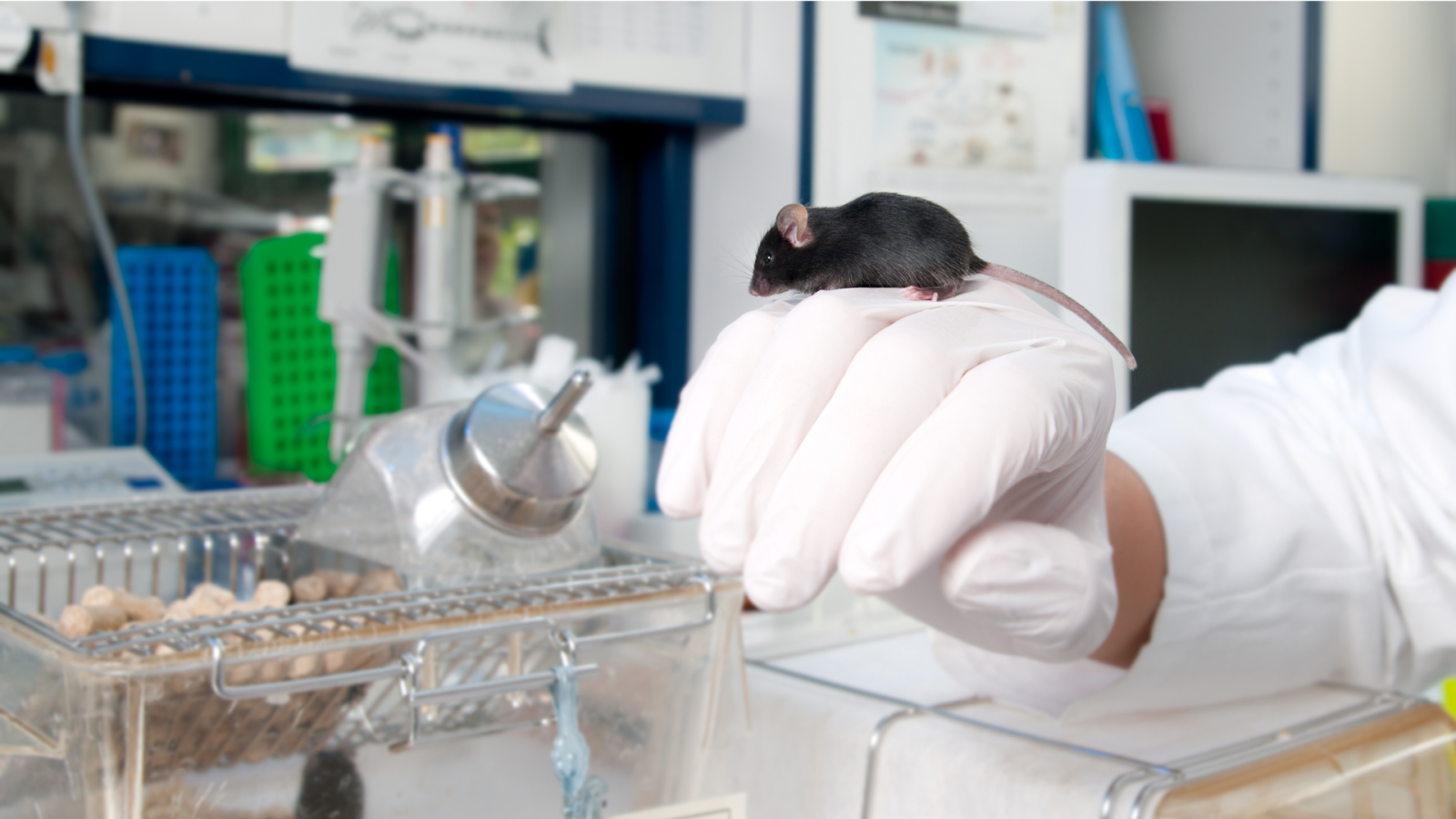La sperimentazione animale rimane uno dei nodi più dibattuti nel panorama scientifico contemporaneo. Ancora oggi è un passaggio fondamentale nello sviluppo di farmaci e terapie, sia per l’essere umano che per gli animali stessi. Si può considerare pratica anacronistica, o più una necessità scientifica condotta con rigore etico senza precedenti nella storia?
Quali sono gli attuali standard etici e normativi e come ci siamo arrivati? E, nonostante i progressi tecnologici, i modelli animali restano ancora oggi insostituibili?
Un tema tutt’altro che scontato, che affonda le sue radici e la sua complessità già nei secoli passati, assumendo un ruolo centrale nel dibattito sulla ricerca biomedica già nei secoli scorsi. Claude Bernard, considerato il padre della moderna fisiologia, utilizzò modelli animali nella prima metà dell’800 con metodi che oggi considereremmo “azzardati”, in nome dell’utilità per il genere umano. Louis Pasteur, condusse studi che portarono al vaccino contro la rabbia e salvarono milioni di vite umane, ma con una metodologia spesso cruenta e priva di regole.
Questa mancanza di regolamentazione suscitò un dibattito pubblico vivace, portando alla nascita delle prime associazioni in difesa degli animali e a un cambiamento filosofico dell’epoca. È Jeremy Bentham a incarnare la lotta per la difesa dei diritti degli animali: la questione per lui non è se una creatura può ragionare o può parlare, ma se una creatura può soffrire. Fu nel 1876 che si arrivò con il Cruelty to Animal Act britannico, alla prima legge che regolamentava la sperimentazione animale, introducendo concetti rivoluzionari: minimizzazione del dolore, giustificazione dell’esperimento e certificazione dello sperimentatore.
Nella mentalità e nei valori etici e morali della società, questi principi diventano sempre più rilevanti. E anche la comunità scientifica li assorbe e li implementa.
Ma arriviamo al ‘900, e in particolare a un caso che portò ad un cambiamento di rotta, alzando l’attenzione sull’importanza dei test di sicurezza nello sviluppo di farmaci, noto come lo scandalo talidomide.
Lo ha ricordato Esi Domi, ricercatrice in biotecnologie all’Università di Camerino, durante il suo intervento al Biotech Week insieme a Giuliano Grignaschi, responsabile del benessere animale degli stabulari dell’Università Statale di Milano, parlando del percorso, tutt’altro che rapido e indolore, di transizione dai modelli animali a nuove metodologie. «La talidomide è un farmaco che fu proposto per il trattamento dell’ansia. La prima volta fu testato su topi di sesso maschile, di certo non in gravidanza. Questa sperimentazione poi fu condotta anche nei topi in gravidanza, una tossicità che non venne rilevata per la prima volta. Il farmaco entrò in commercio e causò migliaia di casi di bambini neonati affetti dalla focomelia». Il farmaco «fu testato poco e sulle specie sbagliate», e neppure si sapeva ancora che la placenta non costituiva un totale riparo per il feto. Stati Uniti rifiutarono di approvare il farmaco, per mancanza di prove sulla sicurezza, così il Paese fu risparmiato dalla tragedia europea. «Il farmaco fu ritestato su un’altra specie, in questo caso sul coniglio, durante la gravidanza e furono riscontrati gli stessi effetti collaterali tragici che erano stati osservati anche nei bambini neonatiı.
Siamo negli anni ’60: da quel momento, i regolamenti dell’FDA cambiarono radicalmente, diventando molto più rigorosi e introducendo fasi obbligatorie di sicurezza sul modello animale prima dell’utilizzo umano.
Ma pochissimi anni prima un sociologo, William Russell e un microbiologo, Rex Burch, scrivono The Principles of Humane Experimental Technique, introducendo per la prima volta il principio delle 3R. Una teoria che rimane sconosciuta fino agli anni ’80, quando è diventata un paradigma che ancora oggi guida l’attività di tutti i ricercatori:
- Replacement: sostituire l’uso di animali ogni volta che sia possibile raggiungere l’obiettivo scientifico con metodi alternativi;
- Reduction: ridurre al minimo il numero di animali utilizzati, mantenendo la significatività statistica dei risultati;
- Refinement: minimizzare la potenziale sofferenza e stress degli animali coinvolti.
«Il principio del refinement spiega perché la maggior parte degli esperimenti (circa 90% nella ricerca di base) viene condotta sui roditori: si ritiene che abbiano una minore capacità di provare sofferenza rispetto a specie superiori come conigli, cani o primati non umani», spiega Giuliano Grignaschi dell’Univeristà di Milano. «Questo giudizio si basa sullo sviluppo del sistema nervoso centrale: animali con minor sviluppo neurologico sono considerati meno capaci di soffrire».
Il dibattito sull’uso degli animali nella ricerca prosegue anche nell’ultimo ventennio: mentre nel trattato di Lisbona del 2006, all’articolo 13, si riconoscono gli animali come «esseri senzienti», ossia creature che non solo provano la sensazione fisica del dolore, ma sono anche in grado di elaborarla, comprendendone la negatività e modificando di conseguenza i propri comportamenti, è la Direttiva europea 2010/63 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici che introduce il concetto delle 3R.
La direttiva rappresenta una roadmap per arrivare un giorno alla completa sostituzione delle procedure sugli animali, a scopi scientifici ed educativi. Ma il legislatore è chiaro: questo potrà avvenire solo non appena questo sarà scientificamente possibile. Nel frattempo, è necessario garantire la massima protezione degli animali. Nel frattempo, un altro passo ancora viene fatto: nel 2013 l’UE vieta l’utilizzo del modello animale per i test sui cosmetici.
Quali sono state le applicazioni in Italia? Il nostro Paese ha recepito la direttiva europea del 2010 con il Decreto Legislativo 26/2014, introducendo alcuni divieti aggiuntivi non previsti dalla normativa europea. Questo ha portato l’Europa ad aprire una procedura di infrazione contro l’Italia. Spiega Grignaschi: «I divieti riguardano, in particolare, l’allevamento di alcune specie come cani e primati non umani (pur permettendone l’utilizzo, costringendo quindi a importarli dall’estero con maggior stress per gli animali), lo studio delle sostanze d’abuso e gli xenotrapianti d’organo, una linea di ricerca che sta ottenendo risultati promettenti».
La normativa europea e italiana identificano otto ambiti in cui è consentito l’uso del modello animale: ricerca di base, ricerca applicata traslazionale, sviluppo e disponibilità di farmaci, test di qualità e sicurezza di farmaci e alimenti, protezione dell’ambiente, conservazione della specie, formazione e addestramento, indagini forensi.
La ricerca di base è volta a capire come funziona la vita senza un’applicazione pratica immediata. La ricerca traslazionale trasforma le scoperte scientifiche in applicazioni pratiche: nuove terapie, strumenti diagnostici, dispositivi medici. È il continuo scambio bench to bedside (dal laboratorio al letto del paziente) e viceversa.
La sperimentazione preclinica regolatoria serve a osservare come si comporta una molecola su un organismo complesso: qual è il livello di tossicità, quale la via di somministrazione ottimale, come viene assorbita ed eliminata. Solo dopo studi in vitro approfonditi, «quando c’è dimostrazione che la molecola possiede potenziali effetti terapeutici, si può passare alla sperimentazione sui animali per vedere come l’efficacia della sostanza permane o si modifica in specifici modelli animali di malattie umane», ricorda Grignaschi.
Anche i dispositivi medici, da pacemaker e neurostimolatori a lenti a contatto e stent, devono essere testati per biocompatibilità prima di arrivare all’essere umano.
Non ricadono nella normativa sull’utilizzo degli animali nelle sperimentazioni invertebrati come la Drosophila (moscerino della frutta), molto utilizzata in genetica, perché considerata non senziente o con un livello di senzienza inferiore; gli unici invertebrati protetti sono i cefalopodi, per l’elevato sviluppo del sistema nervoso dimostrato dalla ricerca scientifica.
Nella ricerca di base e traslazionale, il 90% degli animali utilizzati sono roditori (topi e ratti), seguiti da pesci zebra e polli in percentuali minori.
Nella ricerca regolatoria le percentuali cambiano: compaiono cani, macachi e altre specie perché i regolatori (FDA ed EMA) richiedono animali che forniscano risposte più simili a quelle umane.
Nel gennaio 2023, il presidente degli USA Biden ha emanato una nuova normativa che rende non più “assolutamente obbligatorio” utilizzare animali. Precisa Grignaschi: è l’FDA che «di volta in volta può decidere se nel percorso di approvazione di un farmaco è necessario l’utilizzo degli animali oppure no».
Questo si inserisce nella roadmap recentemente annunciata dal regolatore americano per arrivare gradualmente a non utilizzare più animali, incoraggiando l’inclusione di dati provenienti dalle New Approach Methodologies (NAMs), in vitro, in silico, modelli di intelligenza artificiale, e valuterà caso per caso la possibilità di accettare questi dati in sostituzione parziale e totale dei test sui animali.
Quale è lo stato dell’utilizzo di animali nella ricerca a oggi? Lo racconta Grignaschi: «Mentre nel 2023 in Italia sono stati utilizzati circa 116.000 animali nella ricerca di base e 130.000 nella ricerca preclinica regolatoria, e nella ricerca di base e traslazionale, il 90% degli animali utilizzati sono roditori (topi e ratti), seguiti da pesci zebra e polli in percentuali minori.
Negli Stati Uniti, le statistiche del 2024 mostrano 775.000 animali utilizzati, contando però solo alcune specie. Al contrario di quanto avviene nell’Europa, infatti, negli Stati Uniti, topi, ratti e pesci zebra non vengono censiti. Considerando che l’80-90% degli studi viene fatto sui roditori, i numeri reali del totale degli animali utilizzati negli Stati Uniti si aggirano attorno agli 8-10 milioni di animali».
Anche l’Olanda, pioniera in questo campo con una roadmap pubblicata già nel 2015 per eliminare l’uso di animali entro il 2025, non ha raggiunto l’obiettivo. Nel 2022 è stata pubblicata una nuova roadmap, che stima costi nell’ordine dei miliardi di euro per sviluppare metodi alternativi che consentano di non ricorrere più agli animali. «Anche le roadmap più recenti, insomma, evidenziano (anche dal punto di vista economico) quanto ancora siamo lontani dall’avere metodi in grado di sostituire del tutto gli animali – almeno per ora», ammette Grignaschi.
«L’utilizzo dei modelli animali è moralmente difficile», aggiunge. «Nessuno ama sacrificare un animale a fine sperimentazione, anzi in letteratura sono riportati molti casi di ricercatori e caregiver che hanno abbandonato la loro attività perché non sopportavano lo stress dovuto dal sacrificio dell’animale a fine sperimentazione. L’utilizzo degli animali è estremamente costoso e temporalmente molto sconveniente, lunghi tempi di approvazione e lunghi tempi di esecuzione».
La sperimentazione sugli animali non è infatti un percorso facile. Basti considerare che per utilizzare anche un solo animale in sperimentazione è necessario ottenere un decreto autorizzativo dal Ministero della Salute, come stabilisce il Decreto Legislativo del 2014. Il percorso prevede:
- stesura del progetto di ricerca
- valutazione e parere favorevole dell’Organismo Preposto al Benessere degli Animali) della struttura
- invio al Ministero della Salute
- valutazione tecnico-scientifica (Ministero + ISS)
- verifica delle 3R, della metodologia, della qualificazione del personale
- autorizzazione ministeriale (se l’esito è positivo)
Si parla di una maratona di 4-6 mesi, e i costi si aggirano attorno a circa 1.000 euro solo per avviare il processo di analisi. Il Decreto Legislativo italiano specifica esattamente quali specie, con quali metodi, per quale scopo, chi può operare sugli animali.
Grignaschi continua: «È evidente che se lo stesso esperimento potesse essere fatto con altri metodi, questi 4 o 6 mesi verrebbero guadagnati e si otterrebbero i risultati molto più rapidamente. Non ci sono ragioni logiche accettabili per le quali, se esistono, non debbano essere utilizzate le NAMs. Ma, appunto, deve essere scientificamente possibile».
Alcuni metodi alternativi alla sperimentazione animale esistono, spiega Esi Domi, ma «ritengo che nello studio di diverse patologie si possano considerare approcci non sostitutivi ma complementari alla ricerca animale. Ancora oggi, per esempio, non riusciamo a comprendere bene i meccanismi di diverse patologie collegate al sistema nervoso».
I metodi includono colture cellulari e organoidi, cioè repliche tridimensionali in miniatura di organi o tessuti; organ-on-chip, ossia dispositivi che riproducono la fisiologia del corpo umano; modelli di intelligenza artificiale, predittivi per la frequenza delle patologie. «Modelli che però hanno forti limitazioni: non riescono a riprodurre la complessità del corpo umano, presentano problemi di eterogeneità e standardizzazione. Gli studi mostrano che la ricerca condotta su animali ha una correlazione significativa e positiva con l’utilità clinica rispetto a studi eseguiti solo in vitro», spiega la ricercatrice.
È fondamentale la “validità predittiva” nella scoperta di nuovi farmaci, sottolinea. «Possiamo dire che quasi tutti i farmaci, tutte le medicine, i prodotti medici che sono disponibili oggi sono stati sviluppati con l’aiuto degli esperimenti condotti sugli animali. Grazie alla scoperta fatta sulla ricerca degli animali si sono scoperti antibiotici, la terapia per il diabete, i vaccini, il trattamento per l’HIV. Ricordiamoci anche che se l’80% dei bambini oggi riesce ad avere una terapia per il trattamento della leucemia è anche grazie alla ricerca condotta sugli animali».
I roditori e gli esseri umani, nonostante abbiano un antenato comune di oltre 80 milioni di anni fa, hanno cervelli anatomicamente simili. Le stesse strutture cerebrali del ratto o del topo, seppur più semplici, si ritrovano nel cervello umano. Questo vale anche per altri organi: un cuore umano e un cuore di maiale presentano grande somiglianza anatomica e fisiologica.
Il punto centrale rimane la sicurezza. Grignaschi lo esprime con chiarezza: «Dobbiamo ricordarci che alla fine stiamo parlando della sicurezza di tutti noi. Una volta che prendiamo una decisione, perdiamo qualcosa, qualsiasi cosa noi decidiamo. Può essere meglio, può essere peggio, non lo sappiamo. È solo questione di capire che cosa non siamo disposti a perdere. E dal mio punto di vista la sicurezza dei trattamenti che facciamo arrivare ai nostri pazienti è qualche cosa che non dobbiamo essere disposti a perdere».
Un ambito particolarmente complesso è quello delle patologie psichiatriche. Come evidenzia Esi Domi, «Le ultime statistiche condotte nel 2025 descrivono come i disturbi mentali in Italia siano in potenziale crescita, una crisi invisibile. I dati dicono che una persona su sei convive con l’ansia e la depressione, in Italia ma anche in Europa», con un’incidenza crescente già in età adolescenziale. I modelli animali permettono di studiare disturbi complessi come dipendenze, ansia, depressione, stress post-traumatico, schizofrenia: patologie che richiedono la comprensione di meccanismi neurobiologici ancora largamente sconosciuti. Studi recenti su animali hanno identificato, per esempio, meccanismi di regolazione del neurotrasmettitore GABAergico nell’amigdala centrale responsabili del comportamento patologico nell’assunzione di alcol, con alta traslazione clinica al cervello umano.
La comunità scientifica ha la responsabilità di comunicare apertamente queste tematiche, conclude Grignaschi, uscendo dalla “torre d’avorio” e dialogando con trasparenza. «Solo così ci potrà essere un supporto consapevole alla ricerca biomedica, che resta fondamentale non solo per la medicina umana, ma anche per quella veterinaria e per il progresso scientifico complessivo».