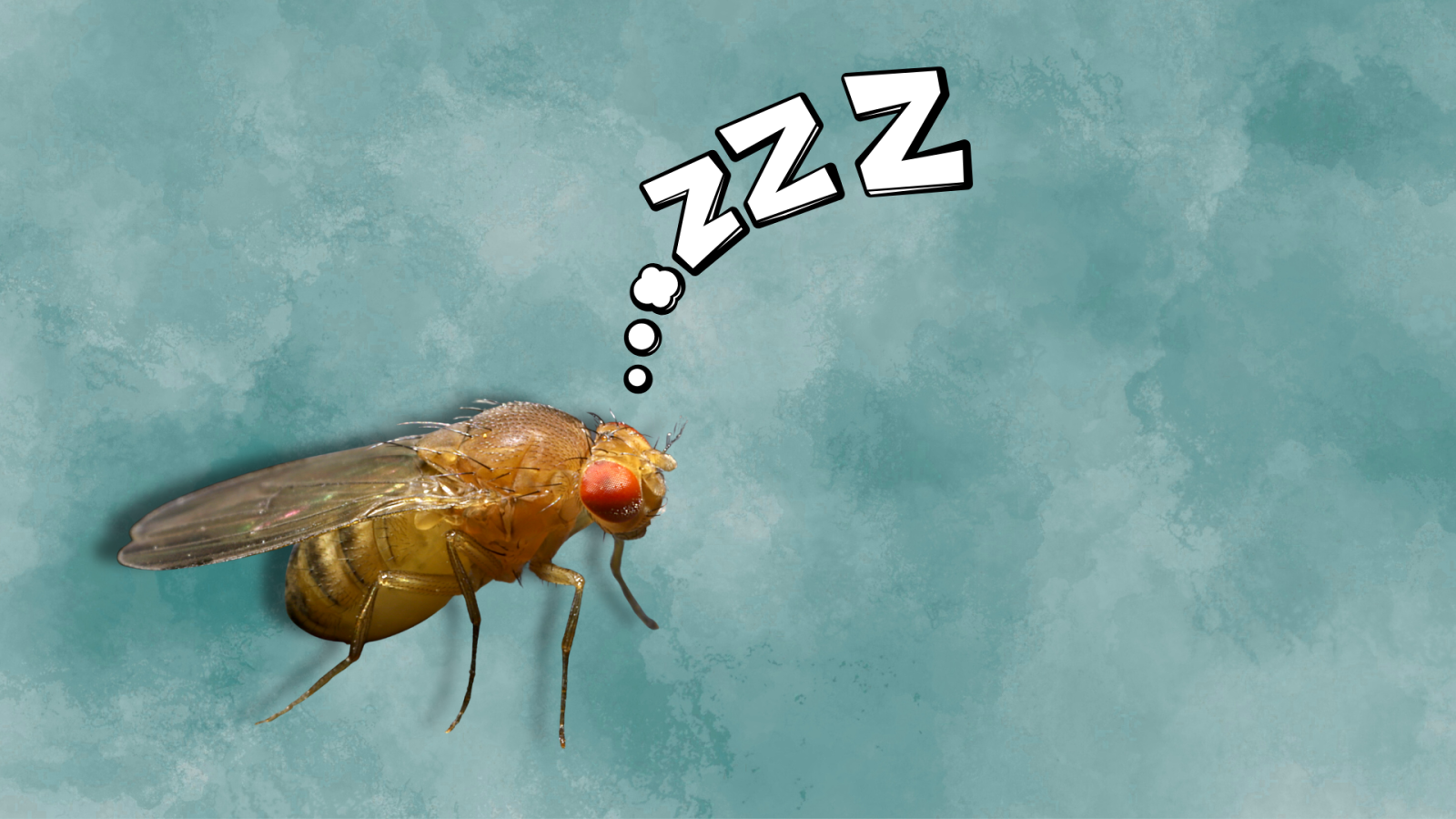Perché dormiamo? La risposta a questa domanda rimane uno dei grandi misteri della biologia. Come scrisse il neurofisiologo Alan Rechtschaffen: «Se il sonno non avesse una funzione assolutamente vitale, sarebbe il più grande errore che l’evoluzione abbia mai compiuto». Dormire, cioè disconnettersi dal mondo per ore, è un comportamento apparentemente rischioso: durante il sonno non possiamo nutrirci, riprodurci o fuggire dai predatori. Eppure, tutti gli animali studiati finora dormono, in forme e con durate diverse: dalle meduse agli insetti, dalle seppie ai draghi barbuti. Ma non sappiamo ancora esattamente perché il sonno sia così universale.
Tuttavia, un indizio forte emerge dal fatto che appena compare un sistema nervoso – anche semplice e non centralizzato, come quello delle meduse – compare anche un bisogno di sonno. È quindi probabile che qualche proprietà intrinseca dei neuroni renda il sonno necessario. I neuroni sono cellule altamente specializzate, che non si rinnovano, e presentano un’attività elettrica continua, un’elevata plasticità e un consumo energetico enorme. Questa richiesta energetica può causare danni cellulari accumulati nel tempo, ed è plausibile che il sonno serva proprio a compensare e riparare questi danni, ristabilendo un equilibrio metabolico.
Sonno e mitocondri
Un nuovo studio pubblicato su Nature e che ho guidato con il gruppo di Gero Miesenböck all’Università di Oxford, suggerisce che la “pressione” a dormire derivi direttamente dal metabolismo energetico dei neuroni. Abbiamo lavorato su Drosophila melanogaster, un organismo modello già cruciale nello studio dei meccanismi circadiani (ricordiamo il Nobel per la Medicina 2017, assegnato proprio alla scoperta dei meccanismi molecolari che li guidano). Ci siamo concentrati su un piccolo gruppo di neuroni cerebrali che regolano l’omeostasi del sonno, detti dFBNs. Attraverso una combinazione di tecniche di trascrittomica a singola cellula, microscopia a singolo e due fotoni, e analisi comportamentali, abbiamo confrontato i neuroni in animali riposati e in moscerini sottoposti a deprivazione di sonno.
L’effetto che è emerso è chiaro: nei neuroni del sonno privati del riposo, geni legati al metabolismo mitocondriale risultano sovraregolati. In particolare, aumentano i geni coinvolti nella catena di trasporto degli elettroni e nella sintesi di ATP, come se i mitocondri stessero tentando di “recuperare” uno squilibrio energetico.
I mitocondri come sensori del bisogno di dormire
I mitocondri sono gli organelli responsabili della produzione di energia attraverso la respirazione cellulare. Il loro funzionamento si basa sul passaggio di elettroni lungo la catena di trasporto, che permette di pompare protoni e di alimentare l’ATP sintasi, generando la valuta energetica della cellula. Nei neuroni privati del sonno, il flusso di elettroni diventa eccessivo e sbilanciato rispetto al consumo effettivo di ATP. Questo provoca un accumulo di stress ossidativo e modifiche strutturali nei mitocondri, come la fissione (frammentazione), la mitofagia (eliminazione dei mitocondri danneggiati) e un aumento dei contatti con il reticolo endoplasmatico, che funge da centro di comunicazione metabolica.
L’aspetto più sorprendente è che questi cambiamenti non sono solo una conseguenza della mancanza di sonno, ma sembrano costituire il segnale stesso che induce il sonno. Per verificarlo, abbiamo manipolato artificialmente la forma e l’attività dei mitocondri: quando gli organelli sono stati indotti a fondersi (diventando più lunghi e interconnessi), i moscerini dormivano di più. Quando invece venivano frammentati, il sonno diminuiva. Lo stesso vale per il gradiente protonico: alterando la “forza motrice” necessaria alla sintesi di ATP, era possibile modulare direttamente il comportamento di sonno-veglia.
Un nuovo legame tra energia, sonno e longevità
Questi risultati forniscono una cornice sperimentale per fenomeni noti da tempo. Gli animali di piccola taglia, con un metabolismo più veloce e un maggiore consumo di ossigeno per grammo di massa, dormono di più e vivono meno. Un topo, per esempio, dorme circa 12 ore al giorno, mentre un elefante solo 3. Questo studio suggerisce che tale differenza possa dipendere dal flusso elettronico nei mitocondri: più elevato è il flusso, maggiore è la pressione ad accumulare “debito di sonno”. Un’altra osservazione riguarda l’essere umano. Chi soffre di malattie mitocondriali sperimenta spesso una stanchezza profonda, anche senza particolari sforzi fisici.
Un’ipotesi che emerge dal nostro studio suggerisce come questo potrebbe essere spiegato proprio dal segnale mitocondriale: un flusso di elettroni “ingolfato” genera una sensazione di esaurimento che potrebbe essere una versione patologica del normale segnale che spinge a dormire.
La conclusione: dormire come conseguenza del respirare
Fino a oggi, il sonno è stato visto principalmente come una funzione che serve al cervello per riorganizzare la memoria, ripulire le tossine e ottimizzare i circuiti neuronali. Tutto questo potrebbe essere vero, ma alla base del bisogno di dormire ci sarebbe allora un fenomeno ancora più fondamentale: la respirazione cellulare. Il flusso di elettroni nei mitocondri non solo produce energia, ma funge anche da “contatore” dell’attività neuronale e del tempo trascorso svegli. Ogni impulso nervoso consuma energia e carica i mitocondri di elettroni, portando il sistema sempre più vicino a uno stato di squilibrio. A un certo punto, diventa necessario “staccare la spina” e riposare, per permettere al metabolismo di ristabilirsi e agli organelli di smaltire lo stress ossidativo.
In altre parole, il sonno non sarebbe solo un comportamento selezionato dall’evoluzione per proteggere il cervello, ma una conseguenza inevitabile del fatto che viviamo respirando ossigeno. Proprio come l’invecchiamento deriva, almeno in parte, dall’accumulo di danni ossidativi prodotti dalla respirazione, il sonno potrebbe essere la pausa necessaria per contenere questi effetti a breve termine.